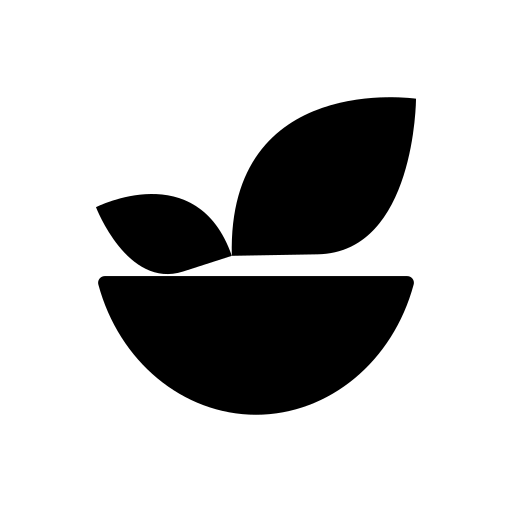- Questo evento è passato.
Relazione. Umani si diventa
18 Aprile @ 18:30 – 19:30
Umani non si nasce, si diventa. Il cammino per diventare umani è quello in cui imparare a raccontare chi siamo, in cui scoprire che, solo attraverso la relazione con gli altri, si possono trovare le parole che danno senso alla nostra storia. Questo cammino non è altro che l’incontro con la propria esperienza. Diventare umani, insomma, significa riconoscere cosa diciamo e chi stiamo diventando, perché è su questa via che possiamo incontrare la felicità.
€12,00
Costo della consumazione
Questo evento è una serata di Nutrimenti. Un esercizio di piacere per il corpo e benessere per l’anima. Nutrirsi insieme è un modo per condividere esperienze e conoscenze con le quali realizzare percorsi di valore.