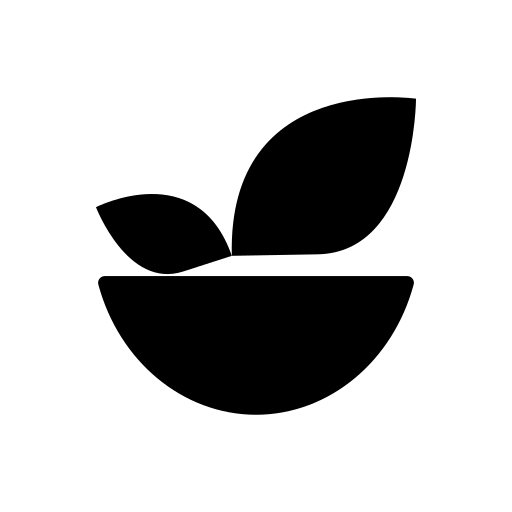L’etimologia della parola «intelligenza» conduce immediatamente al cuore del discorso. Da intus (o inter) e legĕre, l’intelligenza sarebbe quella facoltà – ma anche quell’attitudine che, sviluppata, diventa competenza, e non è perciò né scontata né già acquisita – di «leggere dentro» o «leggere attraverso» gli eventi, i testi, i discorsi, le relazioni e tutto ciò che la realtà offre. In una certa accezione, essa indica il saper «leggere, comprendere, raccogliere idee e informazioni riguardo a qualcuno o a qualcosa»1. Quando l’intelligenza diventa artificiale è a questo senso che, in fondo, il termine allude; ma dal momento che, in tal senso, l’ambito di appartenenza è il mondo del digitale, il significato trascina con sé il riferimento implicito alla mera quantità. Il digitale infatti, in informatica ed elettronica, riguarda ciò che opera manipolando numeri. contrapposto all’analogico che opera invece su grandezze continue. Digitus è il dito, vale a dire lo strumento anatomico che indica, scandisce, separa e, su questa base, conta ed esegue calcoli2.
L’altro versante dell’intelligenza, al contrario, è quello che fa un uso diverso delle preposizioni contenute nell’etimologia della parola. Leggere «dentro» e «tra» non si riferisce più, allora, alla possibilità di connettere le informazioni o di ricavarne una certa mappatura che amplia la disponibilità e la possibilità di sottomettere, per mezzo della conoscenza, una certa porzione del reale. Questo approccio, che la scuola insegna e che ridurrebbe la conoscenza a un repertorio di connessioni, è stato criticato3 proprio in funzione dell’intelligenza artificiale, la quale compie la stessa operazione con una velocità e un’ampiezza di fonti inarrivabile per un essere umano.
Se, però, anziché rimanere intrappolati in questa riduzione quantitativa e ipertestuale dell’intelligenza, ricorressimo al «dentro» e al «tra» come strumenti di esercizio e di sviluppo personale, l’intelligenza assumerebbe tutti altri tratti. In questa veste infatti, essa sposta il suo campo di interesse dalla quantità alla qualità. Leggere attraverso diventa la metafora per esprimere un’attenzione che va alla ricerca di ciò che sta tra le parole, tra le righe, tra gli eventi, tra i discorsi che costituiscono la tessitura delle relazioni. Guardare attraverso un oggetto di interesse, metterlo in controluce, consente di rinvenire in esso il sottotesto, ciò che è implicito, non detto o non ancora pensato, portando in chiaro le cause che limitano chi «legge», che limitano consapevolezza di sé e del mondo circostante.
Il riferimento alla lettura, che, come detto all’inizio, sta nella etimologia stessa della parola «intelligenza» conferma che, qualunque sia il campo d’azione, l’intelligenza è principalmente un’indagine sulle parole con le quali descrivo e intervengo sulla mia esperienza. La lettura, ma ancora di più la scrittura originale e meditata di un testo, apre le parole alla molteplicità e alle relazioni di significato che esse intrattengono l’una con l’altra. Con l’adozione di questo esercizio, tanto lo spessore quanto la rete dei significati e delle relazioni tra parole contribuiscono a radicare queste ultime nell’esperienza. Le parole, cioè, diventano vive, acquisiscono spessore. Anziché venire scandite e indicate come entità singolari e astratte, prendono il corpo di una narrazione.
Tenere un diario, scrivere un racconto, analizzare un concetto con lo sviluppo di un testo sono attività che esercitano l’intelligenza. A partire da qui, questa attitudine cessa di essere quantificata in un quoziente e diventa maestra di vita, perché educa a considerare nei pensieri, nelle parole e nelle azioni – che sono parole in movimento – uno spessore che soltanto i vissuti possono restituire. Allo stesso modo, il mondo e le persone intorno cessano di essere un’enumerazione di individui e diventano intrecci di una storia che ci portiamo impressa sulla pelle.
- ntelligenza, Etimo Italiano ↩︎
- Digitale1 e Digitale2, Vocabolario Treccani ↩︎
- Manzotti R., A che cosa serve ancora imparare”, YouTube, 2024 ↩︎