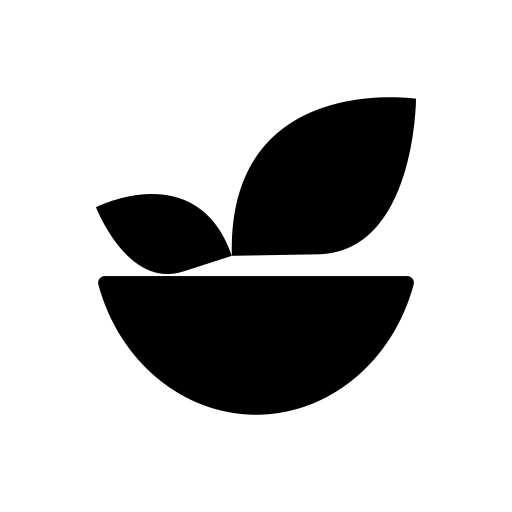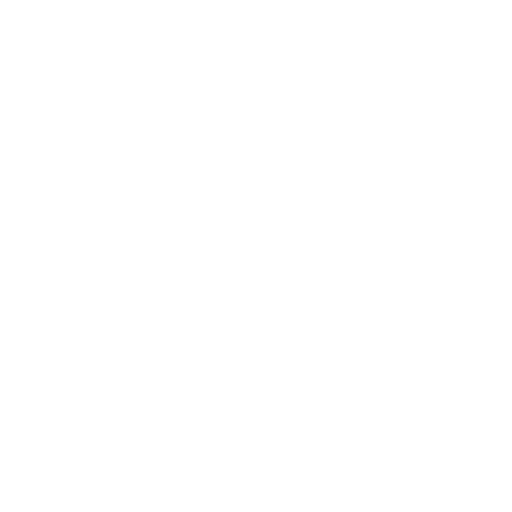Si potrebbe intendere la memoria come qualcosa di statico, inerte, dal momento che gli eventi cui essa si riferisce appartengono ormai a un tempo trascorso. Da questo punto di vista, l’utilità della memoria è limitata a scandire le tappe di un percorso di vita, in modo tale che un episodio giustifichi gli avvenimenti successivi o sia la conseguenza di episodi precedenti. Ricordare, allora, diventa raccontare: mettere in una cornice logica e e di senso l’esistenza o una porzione di essa, dando conto degli affetti e delle esperienze vissute, delle scelte fatte, degli avvenimenti più o meno felici, o più o meno drammatici, che, per la loro rilevanza in quel momento, hanno determinato il nostro stesso percorso, ma che ora, in molti casi, sembrano distanti, irrimediabilmente perduti.
Talvolta, la memoria è ritenuta un ostacolo da eliminare, un materiale refrattario che impedisce di abbracciare i cambiamenti; soprattutto quando questi ultimi sono tali da entrare in rotta di collisione con tutto ciò che li precede e che, pertanto, diventa un legaccio da cui liberarsi al più presto; tanto più se si tratta di ricordi che, per un verso hanno la caratteristica di consolare, ma, per l’altro, generano illusioni senza futuro. In un caso come nell’altro, la funzione della memoria sembra semplicemente quella, per così dire, di far scorrere il tempo, conservando quelle esperienze che promettono ancora un’utilità e rimuovendone altre che risultano superflue o controproducenti. E in effetti, si potrebbe dire, in gran parte le cose stanno proprio così – ma forse non del tutto.
In Materia e memoria, Henri Bergson descrive la memoria, appunto, in due modi: il primo come traccia fisica, una disposizione, causata da un certo movimento, che si conserva nel corpo e che fa in modo, per esempio, di rispondere automaticamente a un oggetto abituale (afferrare una penna o il cambio manuale dell’automobile). Il secondo modo, invece, concepisce i ricordi come entità virtuali; secondo l’autore, essi restano, per così dire, sospesi in un mondo incorporeo, tra il reale e l’inesistente, fino a quando un evento non li richiama per la somiglianza a una situazione precedente; solo a questo punto il ricordo che fra gli altri ha avuto la meglio diventa reale, cioè agisce concretamente realizzando ciò che era appena nascente.
Se la prima modalità di memoria è automatica, la seconda è inconscia. Dunque, è nel riconoscimento e, dove possibile, nella selezione consapevole dei ricordi che questa facoltà incontra il suo valore. Infatti, nel punto in cui la memoria diventa azione, non solo posso rievocare la connessione logica e il senso di un certo avvenimento rispetto agli altri, ma posso anche domandarmi quali abitudini e ricordi sono all’opera e a quali esiti hanno portato.
La memoria è perciò un esercizio costante per rivedere le ragioni dei miei comportamenti, per essere consapevole delle modalità e del percorso con cui essi hanno trovato il loro sviluppo; più in generale, è quello strumento che, quando è utilizzato intenzionalmente, contribuisce a determinare la direzione del mio agire attraverso piccoli ma progressivi adattamenti. La memoria, in questo senso, può essere intesa come un’attività performativa che verifica, qui e ora, passo dopo passo, la coerenza tra l’efficacia dell’immagine che ho di me e la realtà che sto vivendo.
Ricordare, perciò, non equivale più solo a raccontare, ma è un atto trasformativo senza il quale non è possibile indirizzare le scelte. Invece di porsi un obiettivo da raggiungere, una condizione ideale che spesso le contingenze costringono a disattendere, la costruzione di un itinerario fondato sulla memoria dispone alla scoperta e alla ricerca più autentica di sé. I progetti si costituiscono non in base alle aspettative ma come processi aperti i cui risultati sono sottoposti a continua sperimentazione.
Anziché rispondere a un’immagine predeterminata, solo in apparenza sotto il mio controllo, o dichiarare principi e valori stereotipati, che sono memoria, riepilogo, astrazione di un’agire ormai inattuale rispetto all’evoluzione dei tempi, l’uso della memoria attivo e interrogativo – interrog-attivo, se si vuole utilizzare un discutibile neologismo – riconduce le scelte a ciò che avviene qui e ora. Non si tratta, perciò, di rinunciare a porsi dei traguardi con i quali darsi motivazione; si tratta piuttosto di reinterpretarli sulla base delle informazioni disponibili, stabilire, in accordo con le contingenze, un orizzonte temporale al di là del quale qualsiasi previsione è insensata.
In conseguenza a ciò, questo atteggiamento implica una particolare attenzione alla vita che, insieme al godimento del vissuto e all’amore verso sé stessi, si risolve in una certa concezione di stabilità: sapersi sempre in discussione, ma sempre con la sufficiente sicurezza di saperla interpretare.
Memoria, dunque, non significa resistenza al cambiamento. Esattamente al contrario, essa è l’atto con cui incarnare il cambiamento che in ogni istante mi precede e al quale non posso sottrarmi. Quanto più riesco a guardare nel passato, tanto più mi educo alle risorse che il passato mi mette a disposizione per individuare che tipo di futuro le azioni che oggi compio rendono praticabile.
In questo sguardo dilatato, in questa capacità di produrre un’estensione che si spinge avanti e indietro nel tempo, sta il valore della memoria. Ogni istante diventa la mia vita intera, e non quel punto precario, infinitesimale, tra il prima e il poi che noi crediamo costantemente morire. Prova ne è che chi è ricordato diventa alla fine immortale come fonte di ispirazione per altre vite.
In ultima analisi, la memoria è un cerchio che ritorna su sé stesso, a ogni passaggio più ricco, gravido di segni e colori che aspettano di fare ritorno.