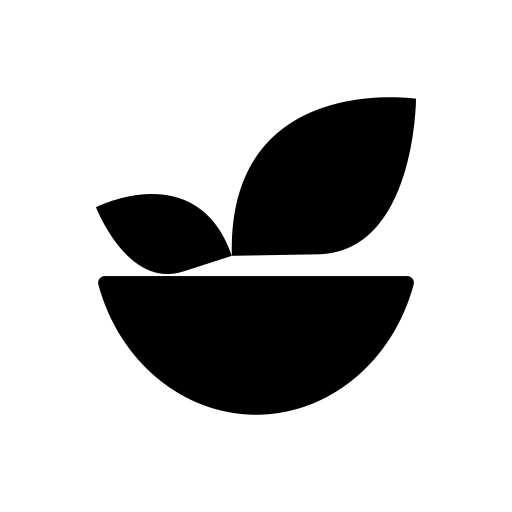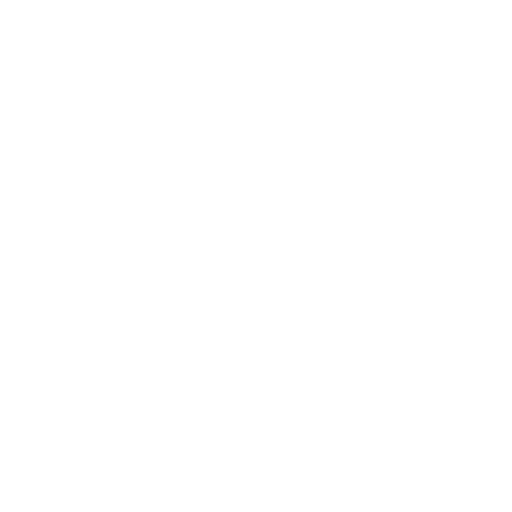La prima voce con cui il dizionario descrive il verbo crescere indica il «diventare più grande, per naturale e progressivo sviluppo, detto dell’uomo, degli animali, delle piante». Questa accezione lascia intendere un significato di crescita come conseguenza di un cambiamento, di un’evoluzione che ha la caratteristica della necessità. Non si può infatti, almeno in termini biologici, non crescere, non modificarsi nel corso del tempo secondo un criterio di misura che prende in considerazione le dimensioni.
Qualcosa di analogo vale in termini metaforici – gli unici peraltro possibili per esprimere un’esperienza interiore, secondo George Lakoff e Mark Johnson in Metafora e vita quotidiana. La nozione abituale di crescita non prescinde da una misura che ne determina il valore: in positivo quando le variazioni di un ambiente o di un vissuto, confrontate con un’aspettativa iniziale, risultano utili per chi le sperimenta; in negativo quando esse vengono disattese.
Ma l’utilità non è mai un obiettivo così chiaro e predeterminato. Il più delle volte essa appare, in una qualche misura, confusa e indistinta, incerta nei suoi contorni che si vanno delineando solo con l’evoluzione degli eventi. Si potrebbe dire che l’idea stessa della crescita nasce soltanto a posteriori, a cose fatte, nel momento in cui, effettivamente, posso affermare con una certa accuratezza cosa stavo davvero valutando. Sono gli effetti finali a determinare i criteri con i quali interpretare l’accaduto. Non è la crescita a stabilire il cambiamento da compiere, ma, al contrario, è il cambiamento a far sussistere la crescita, la quale, una volta avvenuta, allora circoscrivo, misuro, valuto. In altre parole: non si cambia perché si cresce, si cresce perché si cambia; perché il movimento incessante del mondo, tanto quello dei corpi fisici e viventi quanto quello delle relazioni e dei sentimenti che le attraversano, non cessa mai di avvenire. La crescita non è altro che una considerazione provvisoria sullo stato delle cose, relativa al momento in cui la pronuncio. In un certo senso, la crescita è la narrazione di come ho vissuto un’esperienza.
Posta sotto questa luce, più che un fatto o un obiettivo, la crescita somiglia a una conversazione in corso d’opera. L’esito della conversazione non può essere fissato a priori – quando si tratti di un’autentica conversazione – ed è il discorso stesso a stabilire quale direzione prendere, quale evoluzione seguire. D’altra parte, l’intensità delle conversazioni si misura proprio per il grado di imprevedibilità e improvvisazione che comportano, per le illuminazioni talvolta sorprendenti che colgono gli interlocutori. Ogni crescita, come ogni autentica conversazione, è un avventura e un dialogo aperto con il mondo e con se stessi.
Da quanto detto consegue che l’idea di una misurazione della crescita, una misurazione stabilita sulla base di un risultato, mantiene la sua validità solo nel momento in cui gli atti diventano fatti: quando cioè, stabiliti due punti a piacere del percorso, che ne isolano una porzione, è possibile individuare i tre elementi necessari a giudicare una crescita: appunto, percorso, risultato, misura. Si tratta però di una situazione ideale, di un’astrazione, peraltro utile sotto molti punti di vista, che esclude il movimento reale degli eventi. In questa condizione, il dialogo con il mondo si interrompe e, al suo posto, interviene una pura asserzione che congela la crescita in un giudizio senza sfumature. Quasi una sentenza che dice: sì, sono cresciuto, oppure no, non lo sono affatto, e che, come ogni sentenza, presuppone una sanzione e una disapprovazione.
Ma una crescita senza dialogo non è una crescita, è piuttosto una prestazione. Mentre la prima porta beneficio non solo a chi la sperimenta ma anche a coloro che intorno a essa sono parte di quel dialogo, mentre la prima implica una qualità, la seconda è una mera quantità, una tacca, un numero in una serie puntuale e infinita di numeri. Èd è proprio a causa questa irraggiungibile infinitezza che essa includerà nella nozione di crescita il costante riferimento, seppur implicito, alla mancanza, al difetto, alla strutturale insoddisfazione data da un obiettivo ripetutamente spostato in avanti. Non a caso, il filosofo Byung-Chul Han chiama l’ambiente in cui viviamo società della prestazione, destinata a una cronica stanchezza – persino, mi sento di aggiungere, nelle attività più apparentemente orientate al benessere e alla cura di sé – perché aspira non alla vita ma alla salvezza dalla vita, all’essere esentati dalla sua complessità.
Un ultima caratterizzazione che distingue la crescita dalla prestazione riguarda, per così dire, la sua geometria. La prestazione, in quanto serie puntuale e infinita di quantità, non può che assumere l’aspetto di una retta: va da punto a punto e ha una chiara destinazione, fornisce risposte ma non pone domande, cioè non si preoccupa del perché è una retta. All’opposto, la crescita, che in sintesi potremmo definire come la qualità di relazione con il mondo e con se stessi, è un itinerario dalle molte curve e deviazioni che la realtà stessa impone. Ma è proprio il sapersi muovere lungo queste curve, lungo queste deviazioni che la rendono così complessa, è il coglierne le differenti tonalità, a costituire una delle competenze attualmente più importanti da esercitare, oggi che i cambiamenti si sono fatti più che mai incessanti e repentini.